Diceva l’abate Galiani che “les sots font le texte, et les hommes d’esprit font les commentaires”.
Oggi la massima vale – letteralmente – anche per l’editoria: gl’imbecilli scrivono libri e gli uomini di spirito li stroncano.
I libri sull’imbecillità solleticano da sempre la vanità del lettore medio che vi si vede raffigurato quasi fosse un eroe arturiano (a tanto giunge la vanità umana), divertono pure chi se ne crede immune (altra vana pazzia), insomma son libri che – come si dice leggiadramente in ambito editoriale – tirano.
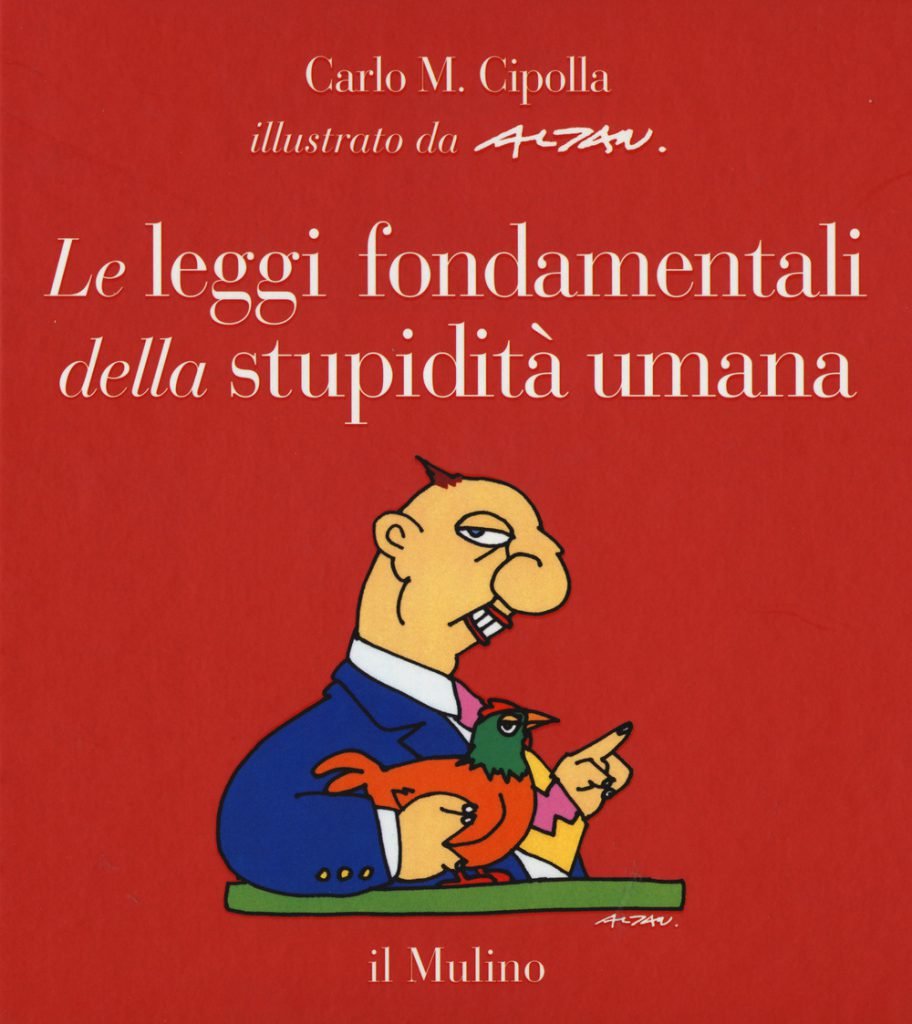 Il Mulino ha pensato bene di doppiare uno dei suoi titoli più smerciati – il volumetto di Carlo Cipolla sulla stupidità umana – con un altro “cipollotto” per dir così, questa volta filosofico. Il professor Maurizio Ferraris non è nuovo a questi libercoli in salsa agrodolce, genere take-away. Filosofo televisivo e trendy (scrisse pure corsivi per Donna Moderna nei quali discettava su come s’indossa una filosofia autunno-inverno), appartiene a quella schiera di pop-philosophers che – tra una metafisica del telefonino e una fenomenologia dell’Ikea – mandano bellamente in vacca la Filosofia, facendole indossare il cappello a sonagli o – se si preferisce – minigonna e zeppe da lucciola.
Il Mulino ha pensato bene di doppiare uno dei suoi titoli più smerciati – il volumetto di Carlo Cipolla sulla stupidità umana – con un altro “cipollotto” per dir così, questa volta filosofico. Il professor Maurizio Ferraris non è nuovo a questi libercoli in salsa agrodolce, genere take-away. Filosofo televisivo e trendy (scrisse pure corsivi per Donna Moderna nei quali discettava su come s’indossa una filosofia autunno-inverno), appartiene a quella schiera di pop-philosophers che – tra una metafisica del telefonino e una fenomenologia dell’Ikea – mandano bellamente in vacca la Filosofia, facendole indossare il cappello a sonagli o – se si preferisce – minigonna e zeppe da lucciola.
Il libro di Ferraris (che è illeggibile e, a dispetto dell’argomento frivolo, assai gnucco) va saggiato alla maniera del cocomeraro col cocomero: bisogna cavarne via solo una piccola porzione, col serramanico, sputandola poi subito s’intende.
In questo genere di roba parauniversitaria è uso cominciare con le paraetimologie (Heidegger docet): abracadabra semantici che dovrebbero svelare chissà quali arcani nelle parole (per questo però ci son già i dizionari etimologici, meno “fondazionali” ma più seri). Con buona pace di Ferraris e dei suoi etimi pindarici, non è l’imbecillità a esser costitutiva nell’uomo (cosa che sarebbe ancora ancora consolante), bensì la malvagità. Il savio Biante volle scrivere sul frontone del tempio delfico Οἱ πλεῖστοι κακοί (“I più sono malvagi”), giacché la stupidità umana ne era un semplice corollario.
Uno dei sommi imbecilli – secondo il professor Ferraris – è Giordano Bruno: “coglione” perché, incaponitosi a difender le proprie idee a costo della vita, al contrario dell’astuto Campanella (poi astutamente in carcere per trent’anni), si fece “arrostire”. Turpitudine filosofica e morale che, per la sua enormità e vigliaccheria, è degna solo d’un qualche cocito “in servigio de’ traditori” della Filosofia o forse d’un’aula magna.
Altro campione d’imbecillità (chiedo venia se l’affianco qui all’immenso Bruno) è Martin Heidegger. Che Heidegger fosse un imbecille – a me – è sempre parso palese, direi cristallino, concordo quindi più con me stesso che con Ferraris, il quale di Heidegger sotto sotto è un epigono, una specie di fan col poster in camera. Lui e i suoi maestri Gadamer e Vattimo (come del resto molti altri filosofi della domenica o da domenicale) debbono a questo nazista in tracht, alle sue fole ermeneutiche e misteriosofiche, fulgide quanto enigmatiche carriere universitarie, collaborazioni giornalistiche, villini e case al mare. Dovrebbero portare in processione il magnifico nazi-rettore, recitarne a memoria Die Selbstbehauptung der deutschen Universität quasi fosse un credo capace di smuover cuori e danari. Oggi invece, dopo la pubblicazione dei Quaderni neri, la fortuna heideggeriana ha svoltato e, similmente agli amici nelle disgrazie, epigoni e imitatori si dileguano oppure tentano comici “distinguo” per salvare capra (Heidegger) e cavoli (loro stessi). Ferraris, che non è Giordano Bruno (ci mancherebbe), non ci pensa nemmeno a soccorrer Heidegger in disgrazia, rischiando magari la propria dorata carriera (“carriera” secondo una nota paraetimologia heideggeriana significa “carro del vincitore”); così lo abiura, chiamandolo pure – per colmo di sfottò e bullismo – imbecille delle Prealpi (e chissà se sul letto di morte, ravvedendosi, dirà E pur si muove il prealpino! chissà?).
Dopo il molto reclamizzato (ancorché per noi indifferente) parricidio filosofico di Derrida, seguito dal matricidio di Vattimo, entrambi a noioso mezzo stampa, Ferraris ci propina ora il nonnicidio di Heidegger (viene in mente Sgalambro: la spassosa definizione di tombeur de philosophe: “C’è pure questo tipo. I filosofi gli passano davanti come in un girotondo. Lévinas succede a Popper che succede a Heidegger a cui succede Gadamer, a cui succede… Questo tipo ‘ama’ i filosofi – non la filosofia”). Beh Ferraris i suoi amati maestri li fa proprio schiattare, li liquida appena non gli servono più: reinterpretazione professorale e pulp del classico Amicus Plato, sed magis amica veritas.
In uno degli ultimi capitoli a Ferraris scappa di dire: bisogna farsi furbi per stare al mondo. Dunque l’opposto dell’imbecille, per lui, è il furbo. Vecchia storia italiana! anche se con la cammesella nuova che le rifila lo spilorcio professore: capo d’haute couture lavorato a Secondigliano. Sul tema aveva già detto tutto Prezzolini nel suo Codicillo, al quale occorre rifarsi per schifare Ferraris e le sue stracotte tartuferie: “Il furbo – scrive Prezzolini – è in alto in Italia non soltanto per la propria furbizia, ma per la reverenza che l’italiano ha della furbizia stessa” e ancora “I furbi non usano mai parole chiare” e infine “Non è vero che l’Italia sia un paese disorganizzato. Bisogna intendersi: qui la forma di organizzazione è la camorra” (pensava forse all’università italiana, Prezzolini?).
Il risvolto di copertina c’informa clangorosamente che il professor Ferraris dirige il “Laboratorio di Ontologia” (purtroppo per l’umanità, la Filosofia e il fisco, non è un refuso di “oncologia”) e che “ha scritto più di cinquanta libri” (nessuno però è un capolavoro, dato che nemmeno il suo editore ne ricorda uno). “Pocas cosas mueren con la rapidez de las ideas y pocos cadáveres inspiran similar indiferencia”, dice Gómez Dávila, ciò è ancor più vero per le ossa dei professori di filosofia – a torto detti dal volgo “filosofi” – che con quelle idee commerciano o tirano a campare.
Marco Lanterna

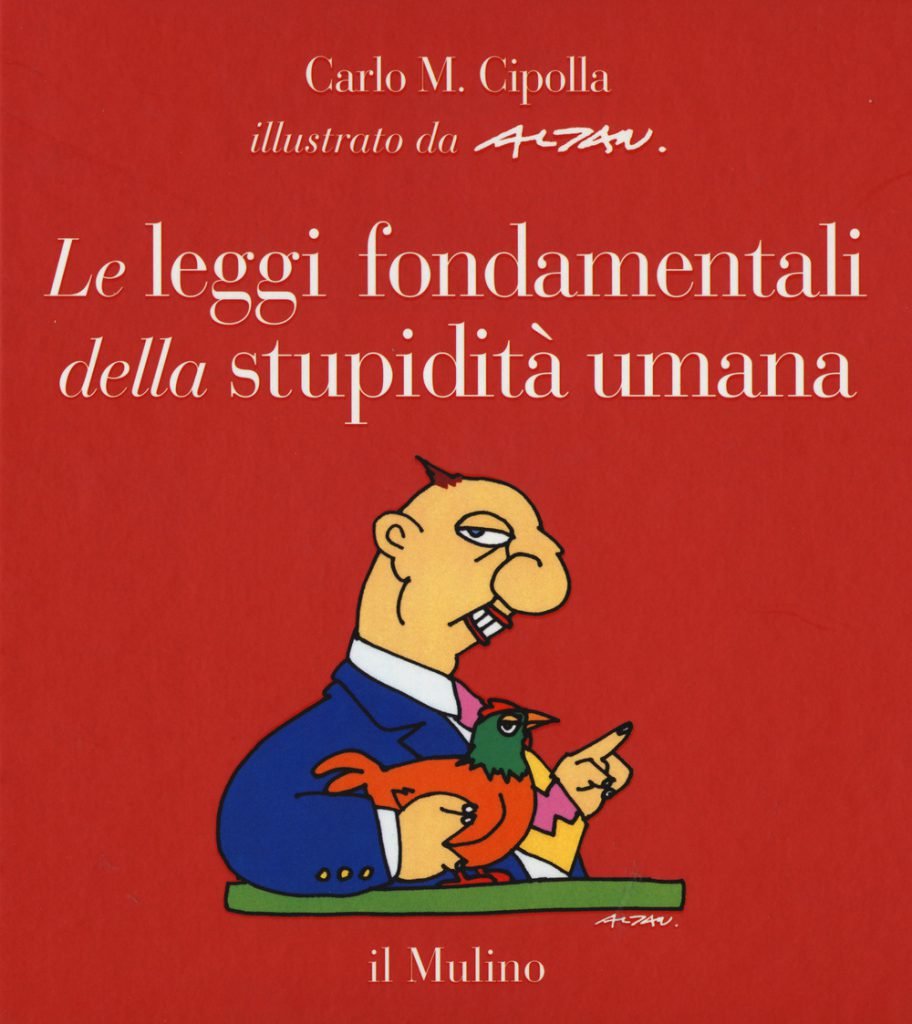 Il Mulino ha pensato bene di doppiare uno dei suoi titoli più smerciati – il volumetto di
Il Mulino ha pensato bene di doppiare uno dei suoi titoli più smerciati – il volumetto di