LE VOCI DEL RIFIUTO – GIORDANO BRUNO
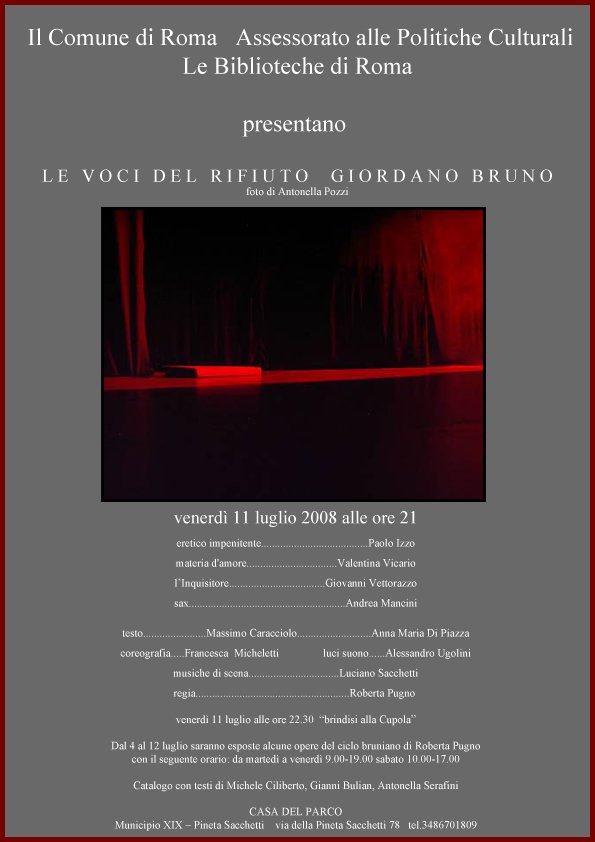
Dopo essere stato messo in scena a Villa Piccolomini nel 2005, al Teatro La Casetta nel 2006 e al teatro Flaiano l’anno scorso, l’atto unico ideato e realizzato da Roberta Pugno viene presentato, con il patrocinio del Comune di Roma e delle Biblioteche di Roma, presso la Casa del Parco a Pineta Sacchetti.
Lo spettacolo si svolge nello spazio retrostante lo splendido casale restaurato recentemente, trasformato per l’occasione in teatro notturno. Alle spalle del pubblico un incredibile paesaggio di distese di campi di grano da cui sorge il Cupolone. “Le voci del rifiuto” è il racconto dello scontro mortale tra un pensiero che rivoluzionò la visione del mondo e la concezione dell’uomo, e la realtà violenta dell’intolleranza e della falsità.
Lui, filosofo superbo, allegro e appassionato, passa da un’immagine all’altra, da un concetto all’altro: l’universo infinito, la pluralità dei mondi, lo spazio continuo, la sostanza sensibile di cui siamo fatti, la dualità dei contrari, l’incessante trasformazione della materia, l’intelligenza dell’amore.
L’altro, invisibile e nero, con voce immobile ne decreta la fine.
Lei ci viene incontro con passi di danza e movimenti ad arco: da dove nasce il rifiuto? da dove nasce il coraggio? da dove la certezza? Il suono del sax, che si intreccia alla voce maschile e che accompagna lo stupore della donna, ci dice quanto sia attuale il rifiuto del pensiero religioso e del pensiero razionale.
Di quanto sia indispensabile oggi più che mai la ricerca della bellezza e della “verità”.

LA SALA DELLE CENERI (di Guido del Giudice)
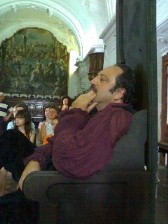
La rassegna teatrale Museum, che per il nono anno è tornata ad animare gli splendidi scenari della Certosa di San Martino è diventata ormai un appuntamento imperdibile del calendario culturale napoletano.
Quest’anno Renato Carpentieri che ne è l’ideatore e l’animatore insieme alla sua “Libera Scena Ensemble” ha voluto impreziosirla dedicando uno degli spettacoli a Giordano Bruno. Giusto assegnare un ruolo di primo piano, in un’iniziativa che si propone di armonizzare cultura e patrimonio artistico di Napoli, ad un suo geniale figlio troppo spesso dimenticato o addirittura maltrattato dai suoi conterranei.
Tra pochi giorni, il sindaco di Montegranaro scoprirà, nella piazza della sua cittadina, una statua dedicata al filosofo Nolano. Napoli, che lo accolse, giovane novizio diciassettenne, nel convento di S. Domenico Maggiore e lo educò e formò sotto quel “benigno cielo” che egli, nel corso della sua lunga e dolorosa peregrinatio, non mancò mai di evocare e rimpiangere, non ha ancora sentito il dovere morale di tributargli un pubblico ricordo.

Chi ha la fortuna di viverli, si consoli almeno con momenti come questo.
La scelta del testo è caduta molto opportunamente sulla Cena delle Ceneri, che ha trovato un palcoscenico ideale in una delle antiche sale della suggestiva certosa, ribattezzata per l’occasione “Sala delle Ceneri”.
Condensare nei 45 minuti dell’azione scenica il profondo e rivoluzionario messaggio del Nolano non era certo facile, ma Amedeo Messina è riuscito nell’impresa firmando una drammaturgia che, senza appesantire eccessivamente l’azione scenica, dosa sapientemente tutti gli ingredienti che fanno della Nolana filosofia un patrimonio prezioso dell’umanità intera e in particolare di quella napoletanità sempre orgogliosamente rivendicata dal filosofo.

Partendo dall’antiaristotelismo e dalla visione cosmologica di un universo inteso come multiverso, infinito e senza centro, il vero obiettivo di Messina è quello di mostrare la costante attenzione del Nolano per il divino, a dispetto della farneticante etichetta di ateismo affibiatagli sia da parte cattolica che anticlericale. Non mancano opportuni accenni ad altri temi importanti della speculazione bruniana, dalla fisiognomica alla magia naturale.
Lello Serao, che ha curato anche la regia, conferisce attendibilità all’interpretazione presentandoci, con la consueta bravura, un Bruno oscillante tra la sofferente ricerca intellettuale e l’istrionica sicurezza di sé che caratterizzarono il suo non facile carattere.
Il risultato è raggiunto grazie anche all’inserimento di alcune trovate sceniche originali e tutte al femminile. E’ il caso della personificazione dell’Ars memoriae, che assisteva Bruno nelle sue spettacolari performance dialettiche, nel personaggio di Mnemosine, interpretato con il dinamismo Ilaria Falinidi un folletto dalla leggiadra Ilaria Falini. Alessia Sirano, dal canto suo, nei panni della padrona di casa Lady Greville, assolve con grazia il compito di ingentilire il ruolo che, nell’opera, è del pedante Prudenzio, trasformandone l’ottusità in sincero desiderio di conoscenza.
Tutti bene in parte gli attori, visibilmente vincolati, essi per primi, dalla magia bruniana, a partire da Antonio Franco (John Florio) che accompagna Bruno, attraverso il fango e la plebe londinesi, al palazzo del suo ospite Fulke Greville (Andrea Marrocco) per una cena filosofica il cui fine è abbattere il velo di diffidenza rappresentato dalla consuetudo credendi dei suoi ospiti, nei confronti delle sue tesi innovative, prima di affrontare l’attacco dei pedanti oxoniensi.
In definitiva uno spettacolo che, pur nella necessaria stringatezza, riabilita, dal punto di  vista teatrale, il testo bruniano dopo la sciagurata devastazione operata un paio d’anni fa da Antonio Latella.
vista teatrale, il testo bruniano dopo la sciagurata devastazione operata un paio d’anni fa da Antonio Latella.
A conferma della riuscita dello spettacolo, Vi propongo questo bellissimo post, tratto dal blog di elisewinfox, invitando tutti coloro che vi hanno assistito ad esprimere le loro impressioni.
Ieri sono riuscita finalmente a ritagliarmi una mattinata per andare a Museum. Il primo spettacolo che ho visto e che m’ha entusiasmato di più di tutti (belli comunque) è stato:
La Cena delle Ceneri con un eccezionale Lello Serao nel ruolo di Giordano Bruno.
Volevo scrivere un post che fosse quanto più fedele possibile alla visione dello spettacolo, raccontando l’ambientazione, di come il pubblico era stato coinvolto, descrivendo minuziosamente l’emozioni di alcuni dialoghi svolti in coro tra Giordano Bruno e la dea Mnemosine, ma purtroppo non ci riesco.
Iniziando a scrivere questo post mi sono resa conto che certe volte è davvero impossibile descrivere le sensazioni che si provano, soprattutto quelle forti, quelle che ti stringono lo stomaco, ti fanno mancare il fiato e ti fanno ritrovare con gli occhi lucidi per la commozione di stare vedendo qualcosa di bellissimo ed unico nel suo genere.
Quelle emozioni che si provano mentre vedi uno spettacolo così e pensi che TUTTE le persone a cui tieni dovrebbero vederlo, perché gli piacerebbe, perché condividono i tuoi stessi pensieri, i tuoi stessi ideali ed uno spettacolo del genere è certamente anche il LORO, ma nello stesso momento, ringrazi di essere da sola a guardarlo quello spettacolo, perché è un momento tutto TUO, un regalo che ti sei fatta.
Avrei voluto descrivere la scena finale, quella in cui si racconta dell’epilogo della vita di Giordano Bruno, quando fu arso al rogo per aver difeso sino alla fine e senza compromessi le idee in cui credeva.
Avrei voluto descrivere, l’emozione che si prova alla fine di uno spettacolo del genere, quando resti un attimo in silenzio, cercando di respirare e di riprenderti da quella morsa che ti ha stretto lo stomaco per poi alzarti, senza rendertene conto, ed iniziare a battere le mani.
Ecco, volevo descrivere tante cose, ma non ci sono riuscita, perché l’unica cosa che può farle capire realmente è ANDARLO a VEDERE!!!
“Una fiamma a Campo de’ Fiori”, il nuovo lavoro teatrale di Alberto Samonà dedicato a Giordano Bruno

Una fiamma a Campo de’ Fiori è il titolo del nuovo lavoro teatrale di Alberto Samonà, autore e giornalista, dedicato a Giordano Bruno, il filosofo di Nola arso vivo nella piazza romana il 17 febbraio del 1600.
Si tratta di un progetto di “teatro narrato” in cui viene raccontato proprio il sacrificio dell’ex frate domenicano, che non volle abiurare i propri convincimenti fino alla morte.
Lo spettacolo, della durata di un’ora e quindici minuti, è un monologo in cui Bruno traccia in prima persona le linee-guida del proprio pensiero esoterico e filosofico. La voce dell’attore protagonista è affiancata da quella di un narratore, che scandisce le fasi della vita dell’ex frate domenicano in un continuo interscambio.
Una fiamma a Campo de’ Fiori verrà messo in scena, in anteprima nazionale, venerdì 24 agosto, alle 21.30, a Villa Piccolo, Capo d’Orlando (Messina), SS. 113 Km 109 (ingresso libero). In autunno sarà la volta di Palermo, e successivamente è previsto un suo allestimento a Roma, per poi proseguire in altre città italiane.
Bruno è interpretato dall’attore palermitano Marco Feo, mentre la voce narrante è di Cesare Biondolillo. L’accompagnamento musicale dal vivo è affidato ad Alessio Pardo (chitarra) e Mauro Cottone (percussioni); le scenografie sono della pittrice Ambra Gioia.
In scena, Giordano legge la realtà dalle pagine del proprio “libro della memoria”. Lo scorrere dei giorni e degli anni è scandito da 22 scene, ciascuna contrassegnata da una differente carta dei Tarocchi e ogni carta sembra interagire con la vicenda umana e spirituale dell’ex frate, il cui contenuto simbolico si intreccia con il significato delle 22 figure. Una fiamma a Campo de’ Fiori ha una scansione del tempo “circolare” in modo che ogni scena, ogni momento ruoti attorno ad un centro, contrassegnato dall’immobilità e dal silenzio.
Il monologo diviene botta e risposta nella sezione dello spettacolo dedicata al processo contro il filosofo nolano e al quale prese parte, in veste di inquisitore, il teologo Roberto Bellarmino. Il processo è, però, occasione per conoscere la visione cosmologica del filosofo, i rapporti con la religione e con il Divino e le fonti tradizionali ed esoteriche alle quali attinge il suo pensiero, da Ermete Trismegisto alla magia naturale di Marsilio Ficino.
Alberto Samonà è giornalista professionista. È stato cronista di “giudiziaria” per vari quotidiani e periodici. È autore di diversi testi a contenuto filosofico e tradizionale. Con questo progetto, è alla sua seconda esperienza di “teatro narrato” dopo Le orme delle nuvole, spettacolo “sufi” scritto nel 2006 dal cantastorie iracheno Yousif Latif Jaralla e tratto proprio da un racconto del giornalista.



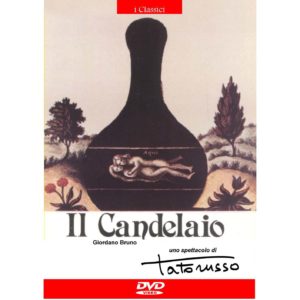


 Ho scelto due piani di lettura. Il primo è la trama, la storia. Il secondo coinvolge la scenografia e si manifesta simbolicamente in un palazzo. Un grande palazzo cinquecentesco che nel corso dello spettacolo si sfalda, regno onirico delle visioni di Bruno. Lì appariranno via via tutti i suoi fantasmi. La follia sessuale, i rabbiosi, complessi rapporti con la donna e la Chiesa, frammenti significativi della sua vita inquieta di esule insofferente… Lo chiamavano “il fastidito”, no? Un po’ come me… e infatti a riscriverlo per la scena mi ha mosso lo stesso fastidio e lo stesso disgusto che lui provò verso la società intollerabile dei suoi tempi.
Ho scelto due piani di lettura. Il primo è la trama, la storia. Il secondo coinvolge la scenografia e si manifesta simbolicamente in un palazzo. Un grande palazzo cinquecentesco che nel corso dello spettacolo si sfalda, regno onirico delle visioni di Bruno. Lì appariranno via via tutti i suoi fantasmi. La follia sessuale, i rabbiosi, complessi rapporti con la donna e la Chiesa, frammenti significativi della sua vita inquieta di esule insofferente… Lo chiamavano “il fastidito”, no? Un po’ come me… e infatti a riscriverlo per la scena mi ha mosso lo stesso fastidio e lo stesso disgusto che lui provò verso la società intollerabile dei suoi tempi.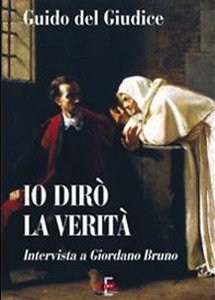
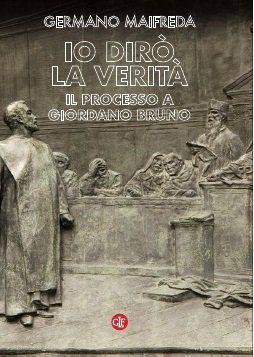
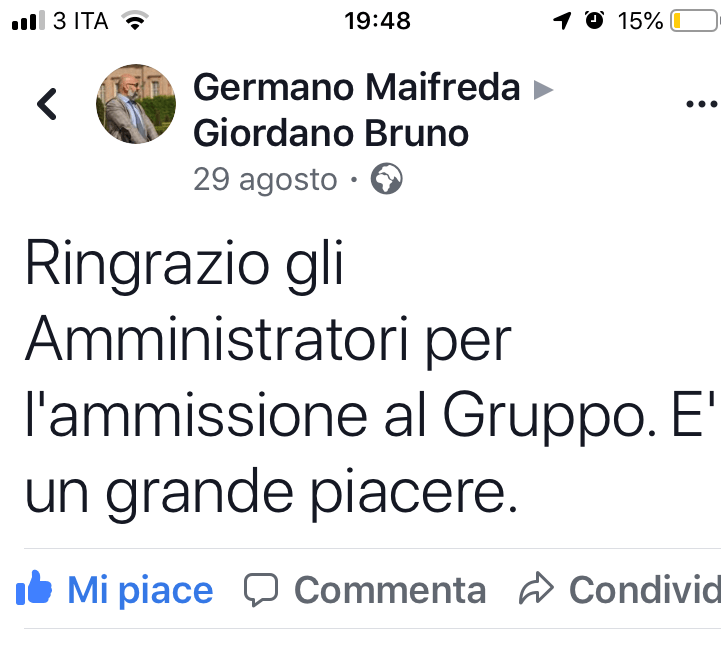
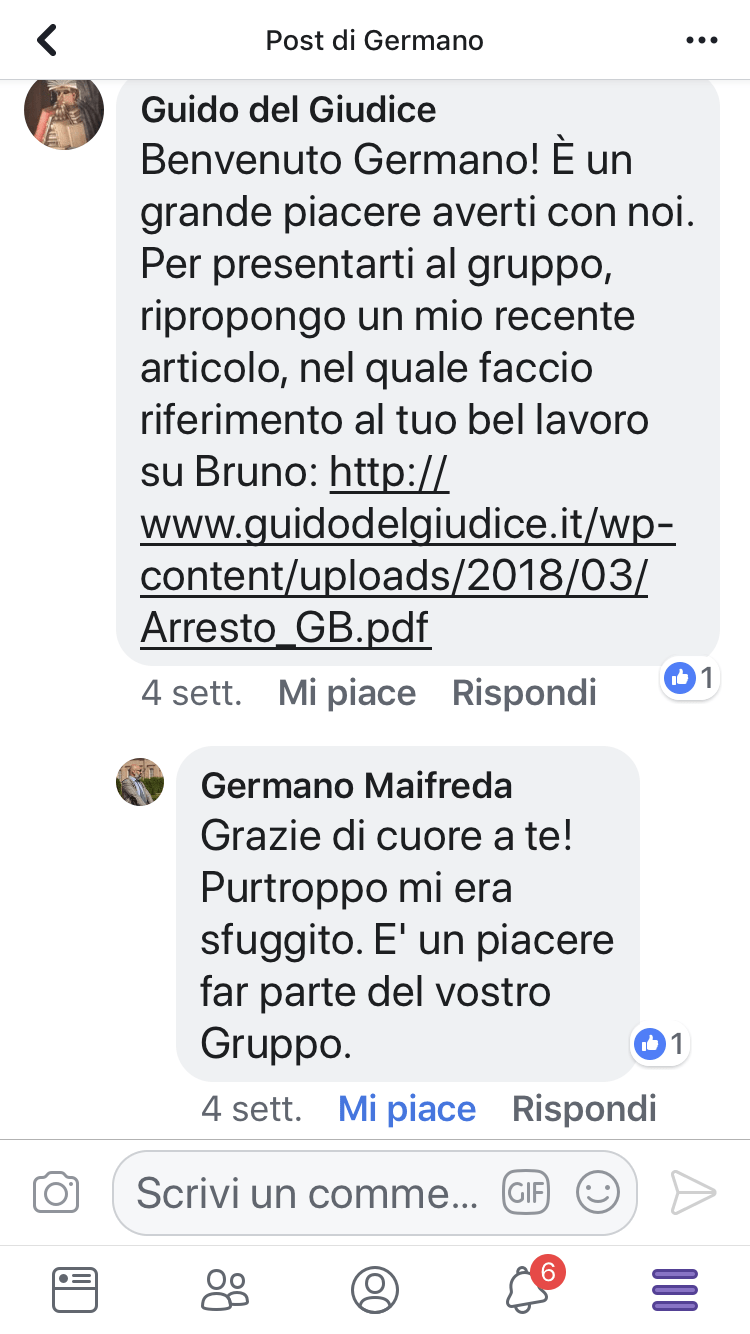


 Dopo lo scritto di Segonds,
Dopo lo scritto di Segonds,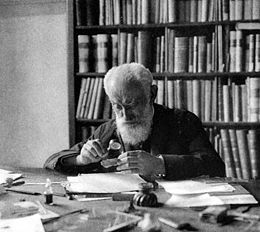
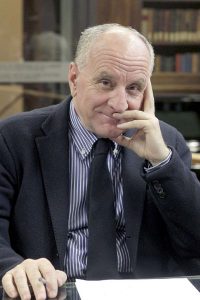 Per quanto riguarda il testo di Bruno, non abbiamo dunque inteso «assorbire» o «oscurare» alcunché: al contrario, fin dal primo momento, nella mia responsabilità di curatore, mi sono preoccupato di segnalare all’editore l’opportunità di utilizzare il testo critico di
Per quanto riguarda il testo di Bruno, non abbiamo dunque inteso «assorbire» o «oscurare» alcunché: al contrario, fin dal primo momento, nella mia responsabilità di curatore, mi sono preoccupato di segnalare all’editore l’opportunità di utilizzare il testo critico di